Introduzione
La Chiesa cattolica, da sempre, ma particolarmente dal termine del XIX secolo, ha prestato notevole e costante attenzione all’evolversi politico, economico e sociale dei popoli proponendo una propria Dottrina Sociale.
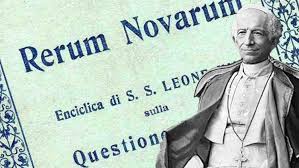 Questo percorso ha come tappe alcune Encicliche o Discorsi dei Pontefici: dalla Rerum Novarum di Leone XIII (1891) alla Quadragesimo Anno di Pio XI (1931), dal Radiomessaggio di Pentecoste di Pio XII del 1 giugno 1951 alla Mater et Magistra (1961) e Pacem in terris (1963) di Giovanni XXIII, dalla Populorum Progressio (1967) alla Octogesima Adveniens (1971) entrambe di Paolo VI, dalla Laborem Exercens (1981) alla Sollicitudo Rei Socialis (1987) alla Centesimus Annus (1991) di Giovanni Paolo II per giungere alla Caritas in Veritate (2009) di Benedetto XVI e alla Laudato sì (2015) e alla Tutti fratelli (2020) di papa Francesco.
Questo percorso ha come tappe alcune Encicliche o Discorsi dei Pontefici: dalla Rerum Novarum di Leone XIII (1891) alla Quadragesimo Anno di Pio XI (1931), dal Radiomessaggio di Pentecoste di Pio XII del 1 giugno 1951 alla Mater et Magistra (1961) e Pacem in terris (1963) di Giovanni XXIII, dalla Populorum Progressio (1967) alla Octogesima Adveniens (1971) entrambe di Paolo VI, dalla Laborem Exercens (1981) alla Sollicitudo Rei Socialis (1987) alla Centesimus Annus (1991) di Giovanni Paolo II per giungere alla Caritas in Veritate (2009) di Benedetto XVI e alla Laudato sì (2015) e alla Tutti fratelli (2020) di papa Francesco.
Accanto ai documenti pontifici sono notevoli pure alcuni testi del Magistero universale: dalla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II (1965) al Decreto Apostolicam Actuositamen (1965), a quelli redatti dalle varie Conferenze Episcopali, fino al Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa (2004) auspicato da Giovanni Paolo II nell’Esortazione Post Sinodale Ecclesia in America (1999) e pubblicato nel 2004 dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace.
Tutta questa documentazione possiede un unico filo conduttore: il “primato della persona” e propone suggerimenti, prevalentemente antropologici, etici e morali affinché l’uomo risulti il centro e il punto di riferimento assoluto ed esclusivo nello sviluppo di ogni settore societario.
Cos’è la Dottrina Sociale della Chiesa
 Essendo complesso fornire una definizione ci riferiremo a Giovanni Paolo II che nel suo lungo pontificato ha rilanciato questa Dottrina.
Essendo complesso fornire una definizione ci riferiremo a Giovanni Paolo II che nel suo lungo pontificato ha rilanciato questa Dottrina.
Il nostro orientamento sarà l’enciclica Sollecitudo Rei Socialis dalla quale attingiamo la definizione, gli obiettivi, la metodologia e le finalità.
Definizione di Dottrina Sociale della Chiesa (DSC). «Non è una terza via tra capitalismo liberista e collettivismo marxista, e neppure una possibile alternativa per altre soluzioni meno radicalmente contrapposte: essa costituisce una categoria a sé. Non è neppure un’ideologia, ma l’accurata formulazione dei risultati di un’attenta riflessione sulle complesse realtà dell’esistenza dell’uomo, nella società e nel contesto internazionale, alla luce della fede e della tradizione ecclesiale» (41).
Obiettivo della DSC. «Interpretare tali realtà (dell’esistenza individuale e collettiva nella società e nel contesto internazionale), esaminandone la conformità o difformità con le linee dell’insegnamento del Vangelo sull’uomo e sulla sua vocazione terrena e insieme trascendente: per orientare, quindi, il comportamento cristiano» (41).
Metodo della DSC. «Dal validissimo apporto di Leone XIII, arricchito dai successivi contributi magisteriali, si è ormai costituito un aggiornato corpus dottrinale, che si articola man mano che la Chiesa, nella pienezza della Parola rivelata da Gesù Cristo e con l’assistenza dello Spirito Santo, va leggendo gli avvenimenti mentre si svolgono nel corso della storia. Essa cerca così di guidare gli uomini a rispondere, anche con l’ausilio della riflessione razionale e delle scienze umane, alla loro vocazione di costruttori responsabili della società terrena» (1).
Finalità della DSC. «Adempiere alla missione di evangelizzare, (dando) il suo primo contributo alla soluzione dell’urgente problema dello sviluppo» (1). Un ampliamento del concetto è presente nella Centesimus Annus. «Per la Chiesa insegnare e diffondere la Dottrina sociale appartiene alla sua missione evangelizzatrice e fa parte essenziale del messaggio cristiano, perché tale dottrina ne propone le dirette conseguenze nella vita della società e inquadra il lavoro quotidiano e le lotte per la giustizia nella testimonianza a Cristo salvatore» (5).
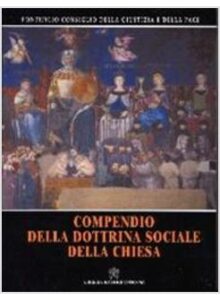 Ebbene, la Dottrina Sociale della Chiesa, partendo dal “primato della persona” che non può essere omesso da nessuna società, attualizzando il concetto di bene comune e i principi etici (dalla solidarietà alla giustizia, dalla sussidiarietà alla partecipazione, alla destinazione universale dei beni…), propone dei modelli per costruire la civiltà a “misura d’uomo” a livello politico, economico e sociale. Possiamo quindi definire la DSC anche un’etica sociale dello scopo, dei doveri e dei diritti oltre che l’annuncio del pensiero del Signore Gesù che il cristiano, sale della terra e luce del mondo, deve comunicare alle realtà temporali. Non è un caso che Giovanni Paolo II, il Papa che nel corso del suo lungo pontificato ha fortemente proclamato il valore della DSC, abbia in molteplici occasioni invitato allo studio di questa disciplina, consapevole che la “nuova evangelizzazione” sarebbe fallita escludendo un’approfondita conoscenza del contributo che la Chiesa Cattolica può offrire alla globalità delle società. Concetto ripreso anche da Papa Francesco nell’Udienza Generale del 5 agosto 2020, rilanciando la DSC della Chiesa come strumento per sconfiggere le problematiche valoriali e strutturali evidenziate dall’emergenza sanitaria pandemica mondiale. «La Chiesa, benché amministri la grazia risanante di Cristo mediante i Sacramenti, e benché provveda a servizi sanitari negli angoli più remoti del pianeta, non è esperta nella prevenzione o nella cura della pandemia. E nemmeno dà indicazioni socio-politiche specifiche. Questo è compito dei dirigenti politici e sociali. Tuttavia, nel corso dei secoli, e alla luce del Vangelo – ha concluso il Papa – la Chiesa ha sviluppato alcuni principi sociali che sono fondamentali, principi che possono aiutarci ad andare avanti, per preparare il futuro di cui abbiamo bisogno».
Ebbene, la Dottrina Sociale della Chiesa, partendo dal “primato della persona” che non può essere omesso da nessuna società, attualizzando il concetto di bene comune e i principi etici (dalla solidarietà alla giustizia, dalla sussidiarietà alla partecipazione, alla destinazione universale dei beni…), propone dei modelli per costruire la civiltà a “misura d’uomo” a livello politico, economico e sociale. Possiamo quindi definire la DSC anche un’etica sociale dello scopo, dei doveri e dei diritti oltre che l’annuncio del pensiero del Signore Gesù che il cristiano, sale della terra e luce del mondo, deve comunicare alle realtà temporali. Non è un caso che Giovanni Paolo II, il Papa che nel corso del suo lungo pontificato ha fortemente proclamato il valore della DSC, abbia in molteplici occasioni invitato allo studio di questa disciplina, consapevole che la “nuova evangelizzazione” sarebbe fallita escludendo un’approfondita conoscenza del contributo che la Chiesa Cattolica può offrire alla globalità delle società. Concetto ripreso anche da Papa Francesco nell’Udienza Generale del 5 agosto 2020, rilanciando la DSC della Chiesa come strumento per sconfiggere le problematiche valoriali e strutturali evidenziate dall’emergenza sanitaria pandemica mondiale. «La Chiesa, benché amministri la grazia risanante di Cristo mediante i Sacramenti, e benché provveda a servizi sanitari negli angoli più remoti del pianeta, non è esperta nella prevenzione o nella cura della pandemia. E nemmeno dà indicazioni socio-politiche specifiche. Questo è compito dei dirigenti politici e sociali. Tuttavia, nel corso dei secoli, e alla luce del Vangelo – ha concluso il Papa – la Chiesa ha sviluppato alcuni principi sociali che sono fondamentali, principi che possono aiutarci ad andare avanti, per preparare il futuro di cui abbiamo bisogno».
Concludiamo con un fraintendimento da superare riguardante la prospettiva economica, non essendo la DSC un manuale di riferimento come affermò Pio XI nell’enciclica Quadragesimo Anno. «La Chiesa non vuole avere nessuna autorità magisteriale sulle questioni di carattere scientifico e tecnico relative all’economia», ma come più volte affermato, «intende solo onorare e promuovere la dignità della persona umana, la sua vocazione integrale e il bene dell’intera società» (2).
Don Gian Maria Comolli (fine prima parte)
