INTRODUZIONE
Paolo VI, al secolo Giovanni Battista Montini (1897-1978), guidò la Chiesa dal 1963 al 1978. Sarà ricordato dalla storia come il Papa dell’attuazione del Concilio Vaticano II. Desiderato e inaugurato dal suo predecessore Giovanni XXIII, toccò a lui concluderlo e, con tenacia e sapienza, accompagnare le prime tormentate applicazioni.
Montini fu uomo di pensiero e di cultura, rammaricato poiché gli assillanti incarichi del suo Ufficio non gli consentivano un maggiore e più frequente contatto con un mondo che tanto amava e apprezzava. Una sua caratteristica personale, propria e inconfondibile, che colpì ammiratori e critici, fu lo sguardo sereno e profondo, dal tratto riservato eppure tanto amabile e cortese.
Paolo VI fu anche il Papa del “dialogo”. Scrisse il filosofo cattolico francese Jean Guitton (1901-1999): «qualunque cosa accada, successo o insuccesso, il Pontificato di Paolo VI sarà ricordato come quello del dialogo con tutti gli uomini» . L’uomo è fatto per il dialogo: questa fu una delle convinzioni che accompagnò tutta la vita di Papa Montini. A questo punto non possiamo scordare il comportamento del Pontefice in occasione del sequestro di Aldo Moro (1916-1978) che intervenne con la “Lettera agli uomini delle Brigate Rosse”, scritta nella notte del 20 aprile 1978. Ne chiede la liberazione «semplicemente, senza condizioni, non tanto per motivo della mia umile e affettuosa intercessione, ma in virtù della sua dignità di comune fratello in umanità». Fu senza dubbio una delle manifestazioni più esplicite dell’importanza che Paolo VI riservò al dialogo; un coraggioso tentativo in cui fece notare il rammarico di “non aver alcun contatto” con i sequestratori, dai quali ci fu solo silenzio. Il dialogo, infatti, non sempre è coronato da successo poiché si può scontrare con posizioni irremovibili, ma è comunque, e in ogni circostanza, un comportamento positivo anche solo l’aver compiuto dei passi per indurre l’incontro con l’altro (don Gian Maria Comolli).
BIOGRAFIA
Secondogenito di Giorgio e di Giuditta Alghisi, Giovanni Battista Montini nacque a Concesio, un piccolo paese del Bresciano, il 26 settembre 1897. Di famiglia cattolica molto impegnata sul piano politico e sociale, tra il 1903 e il 1915 frequentò le elementari, il ginnasio e parte del liceo nel collegio Cesare Arici, tenuto a Brescia dai gesuiti, concludendo gli studi secondari presso il liceo statale cittadino nel 1916.
Nell’autunno di quell’anno entrò nel seminario di Brescia e quattro anni dopo, il 29 maggio 1920, ricevette in cattedrale l’ordinazione sacerdotale dal vescovo Giacinto Gaggia. Dopo l’estate si trasferì a Roma, dove seguì i corsi di filosofia della Pontificia Università Gregoriana e quelli di lettere dell’università statale, laureandosi poi in diritto canonico nel 1922 e in diritto civile nel 1924. Intanto, in seguito a un incontro con il sostituto della Segreteria di Stato Giuseppe Pizzardo nell’ottobre 1921, fu destinato al servizio diplomatico e per alcuni mesi del 1923 lavorò come addetto alla nunziatura apostolica di Varsavia.
Entrato nella Segreteria di Stato il 24 ottobre 1924, l’anno dopo vi fu nominato minutante. In quel periodo partecipò da vicino all’attività degli studenti universitari cattolici organizzati nella Fuci, della quale fu assistente ecclesiastico nazionale dal 1925 al 1933. Nel frattempo, agli inizi del 1930, era stato nominato segretario di Stato il cardinale Eugenio Pacelli, di cui egli divenne progressivamente uno dei più stretti collaboratori, finché nel 1937 fu promosso sostituto della Segreteria di Stato. Ufficio che mantenne anche quando a Pacelli — che fu eletto Papa nel 1939 prendendo il nome di Pio XII — successe il cardinale Luigi Maglione, morto nel 1944. Otto anni più tardi, nel 1952 divenne prosegretario di Stato per gli affari ordinari.
Fu lui a preparare l’abbozzo dell’estremo ma inutile appello di pace che Papa Pacelli lanciò per radio il 24 agosto 1939, alla vigilia del conflitto mondiale: «Nulla è perduto con la pace! Tutto può esserlo con la guerra».
Il 1° novembre 1954 gli arrivò inattesa la nomina ad arcivescovo di Milano, dove fece ingresso il 6 gennaio 1955. Alla guida della Chiesa ambrosiana si impegnò a fondo sul piano pastorale, dedicando una speciale attenzione ai problemi del mondo del lavoro, dell’immigrazione e delle periferie, dove promosse la costruzione di oltre cento nuove chiese. Dal 5 al 24 novembre 1957 tenne una capillare «Missione per Milano», sottoscrivendo nell’occasione un significativo «invito» rivolto «ai fratelli lontani».
Primo cardinale a ricevere la porpora da Giovanni XXIII, il 15 dicembre 1958, partecipò al concilio Vaticano II, dove sostenne apertamente la linea riformatrice. Morto Roncalli, il 21 giugno 1963 fu eletto Papa e scelse il nome di Paolo, con un chiaro riferimento all’apostolo evangelizzatore.
Nei primi atti del pontificato volle sottolineare in ogni modo la continuità con il predecessore, in particolare con la decisione di riprendere il Vaticano II, che si riaprì il 29 settembre 1963. Condusse i lavori conciliari con attente mediazioni, favorendo e moderando la maggioranza riformatrice, fino alla conclusione avvenuta l’8 dicembre 1965 e preceduta dalla reciproca revoca delle scomuniche intercorse nel 1054 tra Roma e Costantinopoli.
Al periodo del concilio risalgono anche i primi tre dei nove viaggi che nel corso del pontificato lo portarono a toccare i cinque continenti (dieci furono invece le visite compiute in Italia): nel 1964 si recò in Terra santa e poi in India, e nel 1965 a New York, dove pronunciò uno storico discorso davanti all’assemblea generale delle Nazioni Unite. In quello stesso anno iniziò una profonda azione di modifica delle strutture del governo centrale della Chiesa, creando nuovi organismi per il dialogo con i non cristiani e i non credenti, istituendo il Sinodo dei vescovi — che durante il suo pontificato tenne quattro assemblee ordinarie e una straordinaria tra il 1967 e il 1977 — e attuando la riforma del Sant’Uffizio.
La sua volontà di dialogo all’interno della Chiesa, con le diverse confessioni e religioni e con il mondo fu al centro della prima enciclica Ecclesiam suam del 1964, seguita da altre sei: tra queste sono da ricordare la Populorum progressio del 1967 sullo sviluppo dei popoli, che ebbe una risonanza molto ampia, e la Humanae vitae del 1968, dedicata alla questione dei metodi per il controllo delle nascite, che suscitò numerose polemiche anche in molti ambienti cattolici. Altri documenti significativi del pontificato sono la lettera apostolica Octogesima adveniens del 1971 per il pluralismo dell’impegno politico e sociale dei cattolici, e l’esortazione apostolica Evangelii nuntiandi del 1975 sull’evangelizzazione del mondo contemporaneo.
Impegnato nel non facile compito di attuare e applicare le indicazioni emerse dal concilio, impresse un’accelerazione al dialogo ecumenico attraverso incontri e iniziative rilevanti. L’impulso rinnovatore nell’ambito del governo della Chiesa si tradusse poi nella riforma della Curia nel 1967, della corte pontificia nel 1968 e del conclave nel 1970 e nel 1975. Anche nel campo della liturgia svolse una paziente opera di mediazione per favorire il rinnovamento raccomandato dal Vaticano II, senza tuttavia riuscire a evitare le critiche dei settori ecclesiali più avanzati e la tenace opposizione dei conservatori, tra i quali l’arcivescovo francese Marcel Lefebvre, sospeso a divinis nel 1976.
Con la creazione di 144 porporati, la maggior parte dei quali non italiani, in sei concistori rimodellò notevolmente il collegio cardinalizio e ne accentuò il carattere di rappresentanza universale. Durante il pontificato sviluppò inoltre in modo considerevole l’azione diplomatica e la politica internazionale della Santa Sede, adoperandosi in ogni modo per la pace — anche grazie all’istituzione di una apposita giornata mondiale celebrata dal 1968 il 1° gennaio di ogni anno — e proseguendo il dialogo con i Paesi comunisti dell’Europa centrale e orientale (la cosiddetta Ostpolitik) avviato da Giovanni XXIII.
Nel 1970, con una decisione senza precedenti, dichiarò dottori della Chiesa due donne, santa Teresa d’Ávila e santa Caterina da Siena. E nel 1975 — dopo il giubileo straordinario tenuto nel 1966 per la conclusione del Vaticano II e l’Anno della fede celebrato tra il 1967 e il 1968 per il diciannovesimo centenario del martirio dei santi Pietro e Paolo — indisse e celebrò un Anno santo.
La fase conclusiva del pontificato fu segnata drammaticamente dalla vicenda del sequestro e dell’uccisione del suo amico Aldo Moro, per il quale nell’aprile 1978 indirizzò un appello agli «uomini delle Brigate Rosse» chiedendone invano la liberazione. Il 29 giugno successivo celebrò in San Pietro il quindicesimo dell’elezione. Morì la sera del 6 agosto, nella residenza di Castel Gandolfo, quasi improvvisamente, dopo un giorno di permanenza a letto. Dopo il funerale celebrato il 12 in piazza San Pietro, fu sepolto nella basilica vaticana.
L’11 maggio 1993 è stata avviata nella diocesi di Roma la causa di canonizzazione. Il 9 maggio 2014 Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito alla sua intercessione.
Paolo VI è stato dichiarato beato il 19 ottobre 2014 da Papa Francesco.
È stato canonizzato da Papa Francesco in Piazza San Pietro il 14 ottobre 2018.
(Tratto da: L’Osservatore Romano del 19 ottobre 2014).
ENCICLICHE
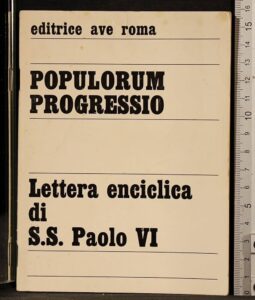
Tra le varie Encicliche di Paolo VI ebbe profondo eco la “Populorum progressio” (1967) riguardante lo sviluppo dei popoli e che ora sinteticamente commenteremo.
L’Enciclica sociale Populorum Progressio (Lo sviluppo dei popoli), indicata da Benedetto XVI: «la Rerum Novarum dell’epoca contemporanea», è uno dei documenti più conosciuti del Magistero di Papa Montini. Promulgata il 26 marzo 1967, l’ enciclica è costituita da due parti, la prima intitolata: “Per uno sviluppo integrale dell’uomo”, la seconda: “Verso lo sviluppo solidale dell’umanità”. Costituì in un periodo di transizione che concludeva tre decenni post-bellici e un intenso sviluppo economico, oltre che demografico, un vigoroso appello alla “giustizia” e alla “solidarietà universale”. In quella situazione, secondo Paolo VI, «la questione sociale ha acquistato dimensione mondiale» (3) ed era urgente una risposta poiché «i popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell’opulenza» (3). In questo contesto, il disinteresse, sarebbe equivalso, per il Papa, affrontare «la collera dei poveri».
Ebbene, Paolo VI colse l’urgenza del cambiamento, proponendo come riferimento imprescindibile la Dottrina Sociale della Chiesa e sviluppando il rapporto da instaurarsi tra individui e nazioni. Non poteva mancare, quindi, la sollecitazione all’abbandono degli egoismi nazionalisti nell’ottica dell’interesse generale della collettività internazionale.
Accanto a queste basi, l’idea che guidò la Populorum Progressio riguardava lo sviluppo che non poteva ridursi alla crescita economica ma doveva essere “integrale”, cioè volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo. Per questo, Paolo VI, disgiungerà il concetto di “crescita” da quello di “sviluppo”. “Crescita” è un vocabolo che si riferisce prevalentemente ai beni materiali, da qui la critica al sistema economico che reputa «il profitto come motore essenziale del progresso economico e la concorrenza come legge suprema dell’economia» (41). Mentre lo “sviluppo”, termine menzionato ottanta volte nel Documento, colloca al centro dell’economia la persona e i suoi valori. Di conseguenza, unicamente lo sviluppo, poteva plasmare un umanesimo planetario, cioè costruire «un mondo, in cui ogni uomo, senza esclusioni di razza, di religione, di nazionalità, possa vivere una vita pienamente umana, superando le servitù che gli vengono dagli uomini e da una natura non sufficientemente padroneggiata» (43). Lo “sviluppo”, inoltre, per Paolo VI era «sinonimo di pace», anzi: «il nuovo nome della pace»(76).
La Populorum Progressio fu oggetto di critiche, talvolta anche feroci, da parte di ambienti economici e capitalisti. Alcuni apostrofarono il Papa come “marxista”, soprattutto per le sue affermazioni riguardo alla proprietà privata, che «non costituisce per alcuno un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno» (23).
Il 27 marzo 1968, nel primo anniversario della pubblicazione del Documento, menzionando quelle reazioni il Pontefice affermò: «È la religione che offre fondamento di giustizia alle rivendicazioni dei non abbienti, quando ricorda che tutti gli uomini sono figli d’uno stesso Padre (…). Potevamo noi tacere, se così stanno le cose? Non potevamo. E perciò abbiamo parlato» (don Gian Maria Comolli).

