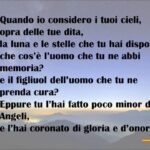 La Dottrina Sociale della Chiesa colloca al centro di ogni riflessione l’uomo, facendo propria la millenaria visione personalista ben riassunta nel salmo VIII che così descrive la persona rivolgendosi a Dio: «Hai fatto l’uomo poco meno degli angeli, di gloria e di onore Io hai coronato: gli hai dato potere sulle opere delle tue mani; tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci che percorrono le vie del mare» (vv. 4-9). E, al termine, il salmista proclama: «O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli s’innalza la tua magnificenza» (v.10).
La Dottrina Sociale della Chiesa colloca al centro di ogni riflessione l’uomo, facendo propria la millenaria visione personalista ben riassunta nel salmo VIII che così descrive la persona rivolgendosi a Dio: «Hai fatto l’uomo poco meno degli angeli, di gloria e di onore Io hai coronato: gli hai dato potere sulle opere delle tue mani; tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci che percorrono le vie del mare» (vv. 4-9). E, al termine, il salmista proclama: «O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli s’innalza la tua magnificenza» (v.10).
Nel salmo osserviamo che l’uomo è posto al centro della creazione, “partner di Dio” nel governo della terra, finalizzata unicamente a lui, poiché la felicità e il perfezionamento della persona erano gli obiettivi primordiali di Dio, e ciò si sarebbe realizzato nella completa e totale comunione Lui.
Questo fondamento della visione personalista è affermato tra i molti da sant’Ireneo: «Gloria Dei vivens homo»( Adversus haereses, IV, 20,7), da san Tommaso d’Aquino sostenendo che la persona umana rappresenta «l’essere più perfetto della natura»( Summa Theologiae, I, q.29,a,3g.), dalla Costituzione Pastorale Gaudium et spes: «anima et corpore unus» (14) e ribadito da papa Benedetto XVI: «non siamo il prodotto casuale e senza senso dell’evoluzionismo. Ciascuno di noi è frutto di un pensiero di Dio» (13 ottobre 2010).

Tutto ciò è legittimato dai primi capitoli del Libro della Genesi dove costatiamo che Dio serba per l’uomo premure e privilegi particolari. E, leggendo la Sacra Scrittura, notiamo che l’uomo nonostante il condizionamento conseguente al peccato originale, e quindi la sua fragilità, è al vertice della creazione, superiore alle creature terrestri, inferiore unicamente agli spiriti celesti, poiché con l’ “intelligenza” scruta, domina e trasforma l’universo; con la “libertà” assoggetta le creature; mediante i “sensi” gusta la bellezza e l’armonia delle cose; per mezzo delle “mani” trasforma la realtà fisica in ciò che desidera. Ma, purtroppo, nel corso della storia e anche oggi in molti manipolano, snaturano, sfruttano e umiliano la persona, modificando, limitando e condizionando la sua sacralità e dignità dal concepimento.
 Accanto a queste caratteristiche della persona non possiamo trascurare sua “natura relazionale” ben tracciata dal filosofo Emmanuel Mounier (1905-1950) riconoscendo che l’uomo non è un’entità giuridica da proteggere nei confronti della collettività, ma un soggetto inquadrato fin dalla nascita in una comunità, assumendo di conseguenza anche un «valore sociale» (cfr., Le Personnalisme, Que sais-je ?, P.U.F., 1949). Giudizio dichiarato anche dal Concilio Vaticano II: «per sua intima natura è un essere sociale, e senza i rapporti con gli altri non può vivere né esplicare le sue doti»(Costituzione Pastorale Gaudium et spes, 12). Pertanto, l’uomo, è fra tutti gli esseri viventi il più comunitario, poiché sia per vivere che per realizzarsi necessita della collaborazione degli altri. Rammenta il teologo e moralista Anselm Günthör: «gli uomini sono, inevitabilmente, legati gli uni agli altri e soggiacciono in molteplici modi gli uni dagli altri; di conseguenza, sono tenuti ad attuare tale legame nel modo giusto per il bene dei singoli e del tutto, e sono responsabili nei confronti degli altri e della comunità così come questa, a sua volta, deve prendersi cura dei singoli membri»(Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale, vol. 3, San Paolo Edizioni 1988, 49).
Accanto a queste caratteristiche della persona non possiamo trascurare sua “natura relazionale” ben tracciata dal filosofo Emmanuel Mounier (1905-1950) riconoscendo che l’uomo non è un’entità giuridica da proteggere nei confronti della collettività, ma un soggetto inquadrato fin dalla nascita in una comunità, assumendo di conseguenza anche un «valore sociale» (cfr., Le Personnalisme, Que sais-je ?, P.U.F., 1949). Giudizio dichiarato anche dal Concilio Vaticano II: «per sua intima natura è un essere sociale, e senza i rapporti con gli altri non può vivere né esplicare le sue doti»(Costituzione Pastorale Gaudium et spes, 12). Pertanto, l’uomo, è fra tutti gli esseri viventi il più comunitario, poiché sia per vivere che per realizzarsi necessita della collaborazione degli altri. Rammenta il teologo e moralista Anselm Günthör: «gli uomini sono, inevitabilmente, legati gli uni agli altri e soggiacciono in molteplici modi gli uni dagli altri; di conseguenza, sono tenuti ad attuare tale legame nel modo giusto per il bene dei singoli e del tutto, e sono responsabili nei confronti degli altri e della comunità così come questa, a sua volta, deve prendersi cura dei singoli membri»(Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale, vol. 3, San Paolo Edizioni 1988, 49).
Attinenti con il concetto di relazione sono quelli di “libertà” e di “autodeterminazione” che oggi godono sempre maggiori consensi ma separati e slegati dalla comunità si autodistruggono.
Don Gian Maria Comolli (fine terza parte)
-Prima parte: Cos’è la Dottrina Sociale della Chiesa
-Seconda parte: Le colonne portanti della Dottrina Sociale della Chiesa
